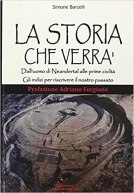 Quella che chiamiamo Preistoria è un’epoca indefinibile in cui i nostri antenati, pur non lasciando tracce di scrittura, hanno comunque disseminato numerose testimonianze di un culto primigenio. Ne La Storia che verrà, un libro uscito nel 2013 per Cerchio della Luna, raccontavo fra le altre cose anche della Dea Madre, effigiata sulle pietre e dipinta sulle ceramiche, che rappresentava valori che vanno oggi scomparendo, quali la fertilità e la natura. I nostri antenati avevano ancora rispetto per l’ambiente in cui vivevano e il recupero di certe convinzioni così radicate deve intendersi come l’obiettivo primario a cui aspirare, se vogliamo migliorare il nostro cammino evolutivo ed evitare l’estinzione. Buona giornata!
Quella che chiamiamo Preistoria è un’epoca indefinibile in cui i nostri antenati, pur non lasciando tracce di scrittura, hanno comunque disseminato numerose testimonianze di un culto primigenio. Ne La Storia che verrà, un libro uscito nel 2013 per Cerchio della Luna, raccontavo fra le altre cose anche della Dea Madre, effigiata sulle pietre e dipinta sulle ceramiche, che rappresentava valori che vanno oggi scomparendo, quali la fertilità e la natura. I nostri antenati avevano ancora rispetto per l’ambiente in cui vivevano e il recupero di certe convinzioni così radicate deve intendersi come l’obiettivo primario a cui aspirare, se vogliamo migliorare il nostro cammino evolutivo ed evitare l’estinzione. Buona giornata!

Tutto il periodo che ancor oggi continua stoltamente, a essere nominato Preistoria (cioè le decine di migliaia di anni prima dell’invenzione della scrittura), rappresenta invero un ricco bacino da cui attingere a piene mani per riscrivere la storia del nostro pianeta e della nostra razza.
Il rinvenimento delle curiose immagini femminili, scolpite sulla roccia, dipinte sulle ceramiche e infine incise sul vasellame, ci porta a considerare la presenza di un radicato culto dedicato alla fertilità, alla natura e alla vita, con il forte simbolismo che può e deve rappresentare la Dea Madre, o Grande Dea, o se preferite Venere, ultima incarnazione di questo imperante femminino nascosto nelle pieghe del passato.
Al riguardo non aveva dubbi l’archeologa e linguista Marija Gimbutas, che dedicò i suoi migliori anni, se non tutta la vita, a inseguire questa conoscenza e rendercene partecipi. Con le sue pubblicazioni del secolo scorso ha apportato nuova linfa allo studio della linguistica e della mitologia e fu lei nel 1956 a introdurre l’ipotesi Kurgan, con cui cercava di spiegare la comunanza di lingua (proto-indo-europeo) delle culture neolitiche del Vecchio continente.
Per quasi trent’anni diresse operazioni di scavo archeologico in numerosi siti neolitici dell’Europa meridionale e orientale, fornendo indicazioni certe per riscrivere numerose pagine del Paleolitico e del Neolitico. Si deve alla Gimbutas la definitiva introduzione della cultura matriarcale nel pensiero accademico allora dominante, da porre in stretto rapporto con le origini indoeuropee.
Un messaggio che per certi versi è caduto nell’oblio, come se non avessimo occhi per vedere e orecchie per ascoltare. O più semplicemente, come se la nostra mente moderna non fosse in grado di andare oltre e interpretare quest’archetipo. Una dea che comincia a lasciare segni tangibili della sua presenza con l’uomo della pietra, che già la immortalava con quelle caratteristiche ormai ben note: seni pesanti e cadenti, natiche enormi, pube in evidenza e grandi occhi.
Un culto che trova la sua maggior penetrazione nel bacino del Mediterraneo, ma arriva prepotentemente anche nel più profondo dell’Europa continentale, se è vero che il nostro antenato soleva rappresentarla utilizzando qualsiasi materiale a disposizione: la pietra, le ossa e il legno. Una divinità che parte da lontano, con i cacciatori del paleolitico, e finisce con gli agricoltori del neolitico, abbracciando quindi l’intero percorso che ci ha condotto fin qui, dove proiettiamo la nostra attenzione più sul futuro che sul passato.
Non per niente questo culto pare essere scomparso completamente ai giorni nostri, sempre che non ci si voglia interrogare davvero sul simbolismo intrinseco della Vergine Maria e di tutte quelle donne divinizzate che, anche in altre religioni, pur avendo un ruolo secondario ricordano straordinariamente la figura della Dea Madre.
Con l’avvento delle grandi religioni succede però qualcosa che sradicherà completamente questo culto. È comunque l’effetto delle continue migrazioni dei popoli indoeuropei, iniziate nel V millennio a.C., con la sottomissione delle società stanzianti a questa gente nomade e l’imposizione di nuovi usi e costumi, non esclusi quelli di divinità maschili da adorare al posto della primordiale dea della natura.
Prima di tutte

Sono trascorsi poco più di dieci anni, eppure la cosiddetta Venere di Tan-Tan continua a rubare il sonno di tanti.Scoperta dall’archeologo Luz Fiedler nel 1999, interrata a quindici metri tra i detriti del fiume Draa a pochi chilometri da Tan-Tan (una cittadina del Marocco), questo reperto, una statuetta in quarzite di appena sei centimetri, è per ora la più antica raffigurazione di una Dea Madre che l’uomo abbia mai rinvenuto.
Comunemente, le viene assegnata una datazione compresa tra 500.000 e 300.000 anni fa (quasi contemporanea della pur controversa Venere di Berekhat Ram, una pietra lavorata rinvenuta nel 1986 a Israele, la cui figurina umana è spesso spiegata come originata da processi geologici), un’esagerazione rispetto ad altri simili manufatti. Eppure quello strato di terreno in cui è stata rinvenuta è datato correttamente al periodo Acheuleano Medio.
Tra le caratteristiche di questa Venere, a parte la cronica mancanza della testa che troveremo ancora, sono soprattutto le evidenti tracce sulla superficie di una sostanza grassa contenente ferro e manganese (che non proviene da giacimenti di ferro naturale corroso, poiché tale pigmento non è stato riscontrato in nessun altro oggetto rinvenuto a Tan-Tan, per esempio le asce di pietra), che potrebbe anche essere ocra rossa, vernice utilizzata dai nostri antenati in una tecnica di colorazione sovente accostata al culto dei morti, quindi senz’altro pregna di valenza simbolica.
Non tutti sono però d’accordo nell’attribuire all’oggetto valore di manufatto: tra questi, Stanley Ambrose della University of Illinois Urbana-Champaign, che la considera una semplice pietra che ha preso quella forma perché levigata dal vento e dall’acqua. Se di madre natura si deve scrivere, ha fatto proprio un bel lavoro, perché sono davvero impressionanti quelle scanalature che ricordano collo, braccia e gambe, senza dimenticarsi di quella leggera patina di vernice.
La verità come sempre potrebbe stare in mezzo, come sostiene Robert Bednarik dell’IFRAO (International Federation of Rock Art Organisations), un luminare di arte preistorica, in uno studio apparso recentemente sulla rivista Current Anthropology: quella pietra modellata naturalmente, potrebbe essere stata percossa ripetutamente con strumenti litici da qualcuno che già vi riconosceva una qualche forma umanoide. Un buon modello, insomma, per dilettarsi in una pur primitiva scultura.
Il contendere tra gli esperti, l’avrete capito, verte sulle capacità intellettive di un paio di nostri predecessori, Homo heidelbergensis e Homo erectus, che vissero in quel periodo, non ritenuti capaci di esprimere un pensiero simbolico in grado di sfociare in questa forma d’arte. Per intenderci, una prerogativa che apparterrebbe solamente all’Homo sapiens.
Una piccola Venere
Quell’avanzamento che riflette la maggior consapevolezza dell’essere riguardo il mondo che lo circonda è evidente nel Paleolitico Superiore (dal 40.000 al 10.000 circa a.C.), soprattutto con le prime raffigurazioni sulle pareti delle caverne e con le statuette, poiché si manifesta con evidenza l’elemento artistico, sicuro indice di cultura e civiltà.
Le immagini parietali sono dedicate per lo più ai mammiferi ma non mancano quelle che cercano di immortalare un ben preciso stereotipo femminino, poi riversato soprattutto in piccole sculture chiamate Veneri del Paleolitico o Dee Madri.
Di statuette preistoriche del genere ne sono state rinvenute almeno un migliaio, in lungo e in largo per l’Europa e presentano identiche caratteristiche. A parte la Cultura gravettiana, cui si deve la maggior parte di queste produzioni, si ricorda qualche esemplare anche della più recente Cultura magdaleniana, attestata al 10.000 a.C.

La più celebre di queste statuette è certamente la Venere di Willendorf, rinvenuta più di cent’anni fa dall’archeologo Josef Szombathy nel sito paleolitico di Willendorf in Austria: è il frutto della Cultura gravettiana ed è stata quindi datata approssimativamente a 25.000 anni fa.
Il reperto, in tutta la sua prorompente bellezza condensata in appena undici centimetri d’altezza, è ancor oggi esposto al Naturhistorisches Museum di Vienna. Si tratta di una scultura in pietra calcarea, decorata con ocra rossa, i cui tratti prorompenti (seno, pancia e fianchi) trasmettono l’idea di fertilità e procreazione, mentre l’ocra rossa potrebbe rappresentare il ciclo mestruale.
La statuetta può senz’altro evocare l’immagine di una dea o di una sacerdotessa praticante lo sciamanesimo, e in questo caso appare innegabile una connotazione religiosa.
Non si distingue il volto, interamente celato da una avvolgente acconciatura o un copricapo a forma di conchiglia, elemento rinvenuto anche in altri simili manufatti ed espressamente riconducibile alla morte e al culto dei defunti; questo carica il manufatto di una duplice valenza, lasciando un alone di mistero.
La grotta della creazione

Appena più recente, qualche migliaio d’anni, è invece la splendida Venere di Laussel, una dea della Dordogna alta quasi cinquanta centimetri e scolpita in bassorilievo. Non siamo in una zona qualsiasi: lì a due passi ci sono le eccezionali pitture rupestri di Lauscaux, complesso definito “La Cappella Sistina della preistoria”.
La nostra Venere è comunque in buona compagnia anche nella sua grotta, con altri bassorilievi raffiguranti teste di cavallo e una scena di parto. Quest’ultima incisione ha consentito di identificare con sicurezza l’anfratto come un luogo di culto dedicato alla procreazione.
Scoperta dal fisico Jean Gaston Lalanne nel 1911, la Venere, oggi conservata a Bordeaux nel Museo d’Aquitania, si trovava all’ingresso della grotta. In origine il bassorilievo doveva essere dipinto di rosso, poiché su seni, ventre e ombelico sono state rinvenute tracce di colorante. Abbiamo già scritto della valenza di questo colore, spesso associato alla fertilità, al sangue e alla vita.
La Venere ha in mano un corno di bisonte su cui il misterioso artista del passato ha inciso tredici tacche. Anche qui siamo di fronte a incontestabili simbologie: da un lato per il corno che, nell’antichità, significava abbondanza e, se pieno di sangue anche la procreazione; dall’altro il numero dei segni che fa il verso ai mesi dell’anno lunare e a quello dei cicli mestruali. Il richiamo alla luna, d’altronde, lo si trovava già nel corno per la sua forma a falce di luna ma ancor di più nella mano sinistra della Venere che è appoggiata sul ventre, a indicare consciamente il nesso tra il ciclo lunare e quello della fecondità femminile.
La Venere Neandertal

I reperti simili rinvenuti in tutt’Europa si sono susseguiti a decine e per alcuni sono state proposte anche datazioni simili alla prima Venere, quella di Willendorf. La paternità degli artefatti, soprattutto statuette, è stata sempre attribuita all’Homo Sapiens in considerazione che l’estinzione del Neandertal era attestata tra 35.000 e 28.000 a.C. circa. Quando qualche reperto è stato datato nel periodo in cui i neandertaliani non erano ancora completamente scomparsi, si è continuato ad attribuirle all’Homo sapiens.
Nel 2006, nella grotta di Hohle Fels in Germania, è stata però riportata alla luce, in frammenti d’avorio poi ricomposti, la Venere (finora) più antica al mondo (escludendo chiaramente la Venere di Tan-Tan e quella di Berekhat Ram, spesso non tenute in nessun conto né dagli archeologi, né dagli antropologi), che si fa risalire a un periodo tra 35.000 e 40.000 anni fa.
Di fronte all’evidenza e in mancanza di resti umani nell’anfratto, l’Homo di Neandertal è tornato protagonista perché a lui andrebbe correttamente attribuita la rappresentazione votiva. La scoperta del manufatto di appena sei centimetri d’altezza si deve alla tenacia del prof. Nicholas Conard dell’Università di Tubinga, che nonostante l’evidenza prudentemente dichiara che “l’uomo moderno, dunque l’homo sapiens, ha risalito la valle del Danubio arrivando nella Mitteleuropa e scacciando l’uomo di Neandertal”. Ma non si può negare a oltranza una verità, seppur scomoda.
Scomparsa nel nulla

Nel periodo Aurignaziano i nostri antenati cominciarono a cambiare abitudini, iniziando a darsi un’organizzazione più complessa: si specializzarono, da una parte gli uomini divennero cacciatori, dall’altra le donne si fecero raccoglitrici. È in questo contesto che i rituali diventano esclusivi, come dimostrano i rinvenimenti in tal senso.
Se nella caverna (o santuario?) francese di Chauvet, circa 34.000 anni fa, sono state rinvenute tracce dei riti magici praticati dai cacciatori (con la rappresentazione di animali sulle pareti), nello stesso periodo (dal 30.000 a.C.), un po’ in tutta l’Europa continentale doveva praticarsi il culto della Dea Madre, certificato dal ritrovamento di numerose statuette, tra cui quella di Willwndorf e quella di Savignano, entrambe databili al 30.000 a.C., le più conosciute.
Il culto della Grande Madre potrebbe essersi sviluppato nella regione del Danubio per poi espandersi verso il Mediterraneo e l’Europa orientale. Siamo nel campo delle supposizioni perché la ricostruzione è indotta dalle rappresentazioni finora rinvenute: da qualche parte, interrata e dimenticata, potrebbe esserci la statuetta in grado di stravolgere ancora il pensiero degli archeologi.
Su questa strada lastricata di dubbi dobbiamo muoverci, e questo percorso parla di un periodo, dal 18.000 al 15.000 a.C., in cui la nostra dea pare scomparire del tutto, almeno nell’Europa occidentale. Dal 15.000 a.C. e per tutto il Magdaleniano, il culto riprende vigore dai Pirenei al Don. Almeno questo crediamo, con le centinaia di statuette rinvenute dappertutto.
Oltre il manufatto

Ci si interroga sulla giusta interpretazione da assegnare a queste riproduzioni di Dea Madre, di là dell’ovvia simbologia. Manufatti che dovevano sicuramente entrare nella vita quotidiana, comprese le cerimonie all’interno dei luoghi sacri. Statuette che in tanti, oggi, tendono a considerare feticci o amuleti per il semplice fatto di immaginare gli antenati ammaliati dalla magia e dediti alle relative pratiche.
Come fa saggiamente osservare il dottore di ricerca in psicologia Pepe Rodriguez, c’è dell’altro, perché a monte di questi oggetti simbolici esiste necessariamente un reticolo di complesse credenze religiose che ancora ci sfuggono, le stesse che permettono poi agli artefatti di trasformarsi in quel che sono, cioè rappresentazioni del potere originario, impregnate della scintilla divina che le rende speciali. Al riguardo non ci sono dubbi nel riconoscere la valenza di un’immagine di culto: la Venere di Laussel, ad esempio. Semmai la questione pare complicarsi non poco quando incontriamo statuette di Dea Madre scheggiate in viso o volutamente decapitate prima di essere inserite in precisi contesti funerari.
Tagliare la testa alle statuette raffiguranti la Dea Madre, di là del significato che poteva avere in origine e che continua a sfuggirci, appare per certi versi un gesto incomprensibile se consideriamo che acconciature e copricapi erano probabilmente la parte che richiedeva più impegno per gli scultori. Queste porzioni che abbellivano il viso erano realizzate a forma conica o di conchiglia (in sostanza un copricapo, come nella Venere di Savignano e in quella di Willendorf) oppure seguivano le forme del cranio (in questo caso rappresentano delle elaborate pettinature, come nella Venere di Bressampouy).
Copricapo o acconciatura avevano comunque la funzione di celare quasi completamente alla vista i lineamenti della Grande Madre, quasi a volerla rendere impersonale. Senza testa la Dea Madre si trasformava, divenendo prezioso collegamento tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
L’antropologo Joseph Campbell è convinto d’aver trovato molte analogie tra il culto della Dea Madre e il mondo dei piantatori tropicali. Affinità da non sottovalutare, perché significa che il culto in parola potrebbe avere un’origine comune che dall’Africa si sarebbe poi esteso in tutto il mondo. Campbell affermò una ventina di anni fa che “…esse rappresentano quella stessa dea madre che sarebbe diventata così importante nelle successive civiltà agricole del Vicino Oriente e che è stata dappertutto celebrata come Magna Mater e Madre Terra.”
Quelle opere d’arte diventano così, meravigliosamente, qualcosa che va di là dell’aspetto solamente ornamentale e sessuale che in tanti hanno voluto vederci: come torna a sottolineare Pepe Rodriguez l’importanza di quelle statuette sta “…nella loro qualità di testimoni muti, oltre che simboli centrali, del primo sistema di credenze religiose strutturate che plasmò la psicologia umana. I concetti, i segni e i simboli che l’umanità paleolitica collegò alla fertilità, alla generazione e al femminile, avrebbero posto la base che permise di ideare le prime formulazioni circa l’esistenza di una divinità datrice della vita e protettrice. Nel corso di più di venti millenni, non vi fu altro dio che la Dea paleolitica; e durante vari millenni ancora essa, attraverso le sue evocazioni, ha continuato a dominare l’espressione religiosa delle differenti culture del continente eurasiatico e del Vicino Oriente.”
